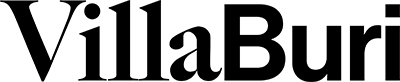L’industria della moda è uno dei settori più inquinanti e meno sostenibili al mondo. Negli ultimi decenni, il fenomeno del fast fashion ha reso il consumo di abbigliamento un’abitudine usa e getta, con gravi conseguenze per l’ambiente e per le persone che lavorano in questo settore. Produzione intensiva, spreco di risorse, inquinamento e sfruttamento del lavoro: tutto questo è il prezzo nascosto dei vestiti a basso costo che riempiono i negozi e gli armadi di milioni di persone.
Tra il 2000 e il 2020, in Europa la produzione di abbigliamento è raddoppiata, passando da 58 milioni di tonnellate a 109 milioni di tonnellate, con la previsione di arrivare a 145 milioni nel 2030. Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente (Aea), viene stimato un consumo medio di prodotti tessili per persona all’anno pari per esempio a 400 metri quadrati di terreno, 9 metri cubi di acqua, 391 chilogrammi di materie prime, con un’impronta di carbonio di 270 kg.
Ogni fase della produzione di un capo di abbigliamento ha un impatto devastante. La coltivazione del cotone, per esempio, richiede enormi quantità d’acqua: per produrre una semplice t-shirt ne servono circa 2.700 litri, mentre per un paio di jeans il consumo va dai 7.000 ai 10.000 litri. Numeri che fanno riflettere, soprattutto considerando che molte delle aree in cui viene coltivato il cotone, come l’India e il Pakistan, soffrono già di gravi crisi idriche.
Ma il problema non è solo l’acqua consumata, bensì anche quella che viene inquinata. Il processo di tintura e trattamento dei tessuti è responsabile del 20% dell’inquinamento idrico globale, con sostanze chimiche tossiche che finiscono nei fiumi e nei mari. A questo si aggiunge l’enorme rilascio di microplastiche dai tessuti sintetici, come il poliestere, che ogni anno immettono negli oceani l’equivalente di 50 miliardi di bottiglie di plastica.
Anche le emissioni di gas serra sono allarmanti: il settore moda è responsabile del 10% delle emissioni globali di CO₂, superando quelle prodotte dall’intero settore dei trasporti aerei e marittimi messi insieme. Il problema è reso ancora più grave dall’utilizzo di combustibili fossili nelle fabbriche e dalla logistica necessaria per trasportare i capi da un continente all’altro.
Oltre all’impatto ambientale, anche il trattamento d* lavorator*, la trasparenza e il “fine vita” degli abiti concorrono a definire l’indice di sostenibilità di un brand.
L’altro volto della moda: sfruttamento e precarietà
Il fast fashion si regge su un sistema di produzione basato sullo sfruttamento della manodopera. La maggior parte dei vestiti a basso costo viene prodotta in paesi come Bangladesh, India, Vietnam e Cina, dove le condizioni di lavoro sono spesso disumane. Orari massacranti, salari da fame e ambienti insicuri sono la norma. Il caso più tragico è stato il crollo del Rana Plaza in Bangladesh nel 2013 che ha causato la morte di oltre 1.100 lavorator*. Un evento che ha acceso i riflettori sulle condizioni delle fabbriche tessili, ma che non ha portato a cambiamenti concreti nel modello di produzione.
Lo sfruttamento riguarda anche persone più piccole: secondo l’International Labour Organization, circa 170 milioni di bambin* nel mondo lavorano nell’industria tessile. Molt* di loro sono impiegat* nella raccolta del cotone o nella cucitura degli indumenti, in ambienti privi di tutele e con gravi rischi per la salute.
La cultura dell’usa e getta
La moda è diventata sempre più veloce: nuove collezioni vengono lanciate ogni settimana, spingendo consumator* ad acquistare sempre di più. Negli ultimi vent’anni, la produzione globale di abbigliamento è raddoppiata, ma la durata media dei capi si è dimezzata. Oggi, un vestito viene indossato in media sette volte prima di essere scartato, finendo spesso in discarica o incenerito. Il risultato? Ogni anno l’industria della moda genera 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, mentre solo l’1% dei materiali viene realmente riciclato per creare nuovi vestiti.
È possibile una moda sostenibile?
Cambiare il sistema moda è una sfida enorme, ma sempre più persone stanno prendendo coscienza del problema. La moda del re-fashion produce capi di vestiario realizzati con stoffe di riciclo, molti marchi stanno investendo in materiali sostenibili, come il cotone biologico, il Tencel o il Piñatex, una fibra ottenuta dagli scarti dell’ananas. Anche l’economia circolare sta guadagnando terreno, con iniziative di seconda mano, upcycling e riciclo tessile.
A livello individuale, ci sono piccole scelte che possono fare la differenza: acquistare meno e meglio, optare per brand etici, preferire il second hand e riciclare i propri vestiti invece di buttarli. Il vero lusso oggi non è comprare tanto, ma scegliere con consapevolezza.
FONTI
“Fast fashion: l’insostenibile costo ambientale e sociale” su Infobuildenergia
“Fast Fashion: una moda insostenibile” su Azzeroco2
“L’insostenibile leggerezza del sistema moda” su Il Bo Live UniPD
“Fast fashion, la moda insostenibile che inquina e sfrutta” su lavialibera
“Fast fashion: il lato oscuro della moda e i diritti negati” su blog.geografia.deascuola.it